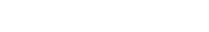Siamo arrivati al quinto switch-over, con Roma e parte del Lazio il 16 giugno. Il modello di transizione al digitale scelto dall’Italia é quello legittimato dalla legge Gasparri e dal Testo unico sulla radiotelevisione. Tale modello si basa su una moltiplicazione dei canali in assoluta continuità con l’assetto analogico e i suoi rapporti di forza. In analogico, solo Rai e Mediaset avevano tre reti nazionali, le uniche sei con una copertura superiore al 90% del territorio. Questo vantaggio competitivo si è trasferito nell’assegnazione delle frequenze digitali, una per multiplex.
In Sardegna, cinque reti Dvb-T più una in Dvb-h per Rai, altrettante per Mediaset (ma il Dvb-h non sta andando incontro a un fallimento di mercato?). Telecom Italia Media è (era) a quattro reti, Rete A-L’Espresso a due, gli altri operatori a una (ReteCapri, H3G, Europa 7). La disparità nell’assegnazione della capacità trasmissiva è destinata a pesare ancor più quando si partirà con l’HD, tanto che, al momento, solo Rai e Mediaset progettano le trasmissioni in Alta Definizione.
Il compromesso raggiunto dal Governo con la commissione Ue, basato su cinque frequenze da assegnare con procedure competitive, non cambierà di molto lo scenario. Un pacchetto di due delle cinque frequenze, infatti, sarà assegnato, probabilmente con beauty contest, ai migliori progetti e Rai e Mediaset partono nettamente favoriti: sarà questa la loro quinta rete digitale terrestre (quattro le avranno in eredità) alla quale si aggiungerà quella di tv mobile in Dvb-h, la sesta rete.
Una considerazione banale ma che non ho mai sentito fare in decine di convegni: se i programmi-canali aumentano per tutti – ma per qualcuno di più – lo squilibrio delle risorse non si riproduce tale e quale ma si accresce. Le televisioni locali hanno assicurato il loro consenso a questo modello di transizione in cambio dell’assicurazione di avere una frequenza per ciascuna emittente. A parte che in alcune regioni questo sarà quasi impossibile (Veneto), la maggior parte delle emittenti ha poche risorse, in parte drenate dalla necessaria conversione degli impianti. Quali diritti e produzioni potranno contrapporre alle decine di canali nazionali dei maggiori operatori? Si moltiplicheranno le aste in digitale? O molte, come già accade, noleggeranno questa capacità trasmissiva in eccesso (alla pay tv a luci rosse, magari) o attenderanno qualche compratore?
Si tratta, quando si parla di risorse, non solo di quelle economiche – monopolio del canone per la Rai, posizione dominante di Mediaset sul mercato pubblicitario televisivo e di Sky nella risorse a pagamento – ma di accumulo dei diritti di trasmissione multipiattaforma per il free, il pay e la pay-per-view. Risultato: resta elevato l’accesso al sistema tv per eventuali nuovi entranti, se questi volessero fare tv di qualità e fare concorrenza ai generi televisivi di successo.
C’è poi un altro aspetto del modello italiano che avrà effetti sull’assetto industriale del settore è quello dell’integrazione verticale dei principali operatori. Anche in questo caso vi è una perfetta continuità con l’assetto analogico, dove l’integrazione tra rete di trasmissione e broadcaster ha un senso, quello dell’equivalenza tra frequenza e programma trasmesso. In ambiente digitale, come accade in quasi tutto Europa, si è andati verso la separazione proprietaria tra le diverse missioni, permettendo ai broadcaster di concentrarsi nella produzione e distribuzione dei contenuti sulle varie piattaforme. Il modello Sardegna ha legittimato l’integrazione tra operatore di rete ed editore di contenuti. Questa mancata separazione (quella societaria, ma non proprietaria, non cambia l’assetto verticale di gruppo) impedisce l’ingresso di nuovi operatori nella rete di trasmissione e rende ardua una concorrenza sui contenuti quando, anche senza intuibili pratiche di favore infragruppo, gli editori “puri”, quelli senza rete, dovranno aggiungere al costo dei programmi anche quello per il noleggio della capacità trasmissiva.
Ultimo argomento, non per ordine d’importanza: nel modello italiano non è previsto, al momento, alcun dividendo digitale a favore della banda larga mobile, come, anche in questo caso, nel resto d’Europa. Nel 2015 i canali dal 61 al 69 dovrebbero essere dedicati anche a tale scopo, secondo le direttive che hanno seguito la Conferenza di Ginevra del giugno 2006. In Italia, in questi mesi, i canali dal 61 al 69 vengono assegnati all’emittenza televisiva (in gran parte a quella locale). È pensabile dire a un’emittente “dopo cinque anni di attività in digitale ora devi spegnere?”.
Il modello italiano, in sintesi, appare lontano dall’Europa come quello analogico, non incoraggia gli investimenti di nuovi entranti, nazionali e comunitari, non aiuta la crescita della competizione e della qualità dei contenuti televisivi, non tramuta l’aumento della quantità dei canali in un assetto concorrenziale tra editori che competano alla pari, noleggiando la capacità trasmissiva da un operatore “terzo”. Conta qualcosa tutto questo? Avanti tutti: operatori, associazioni, governo, Authority. Il digitale terrestre non può fermarsi. È vero, ma un determinato modello può fermare la crescita del sistema televisivo e della cultura nazionale. E lo sta già facendo.
(http://marcomele.blog.ilsole24ore.com)