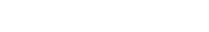Il finanziamento pubblico serve ancora, se i giornali non muoiono prima
A dare un’occhiata agli scaffali delle edicole, la profezia dell’Economist sulla scomparsa dell’ultimo quotidiano nel 2043 parrebbe persino ottimistica. Non lo è, di sicuro, per le piccole realtà come il quotidiano tarantino Corriere del Giorno di Puglia e Lucania, “morto” prematuramente all’età di 67 anni. Il modello della cooperativa pura si è infranto sulla durezza dei numeri di bilanci ballerini; e ciò nonostante i contributi pubblici all’editoria che, da più parti, si vorrebbe eliminare: una idea che, al contrario, può sembrare un’inutile crudeltà.
I giornali, infatti, stanno tirando le cuoia ben prima che il “grillismo” riesca ad attuare la sua “soluzione finale”. Una bandiera anti-casta che colpisce nel mucchio, alla cieca. Anzi, in modo ottuso perché – anche questo si è ascoltato – “i giornali non parlano bene di noi”.
Ma, in realtà, c’è davvero bisogno di finanziare l’editoria? Dipende, soprattutto, dal come lo si fa. Il finanziamento pubblico ai giornali, in particolare quelli in cooperativa, dev’essere finalizzato a dare voce al pluralismo in cui si sostanziano la democrazia, la libertà d’informare e d’essere informati. Non solo.
È necessario finanziare giornali che producano vendite in edicola, lavoro e contratti giornalistici veri. Giornali che, certo, devono rispettare le regole stringenti sui requisiti d’accesso previsti nella legge 103 del 2012 (certificazione delle vendite, numero minimo di contratti a tempo indeterminato e tracciabilità dei pagamenti), ma che devono poterlo fare da (redi)vivi. Il particolare non è secondario, se pure un meccanismo salva-cooperative come il comma 7bis dell’articolo 1 sinora, a parte il caso di scuola del Manifesto, non ha dato grandi risultati.
Il fatto è che questo marchingegno è stato studiato per lo scenario di crisi attuale ma con gli strumenti del 1981, anno della famosa lex specialis numero 481. Da allora l’editoria è cambiata radicalmente: i poligrafici, se ancora ne esistono, hanno cambiato mestiere e i giornali stanno svanendo o stanno cambiando pelle. La carta stampata ha perso sempre più colpi, surclassata prima dalla tv e poi dal web.
Ma questa evoluzione (o involuzione?) è stata consumata a danno dei giornalisti, sempre più “cinesizzati”. Il ciclo di un prodotto culmina nella sua standardizzazione e un prodotto “maturo” viene realizzato nelle realtà emergenti, a basso valore aggiunto e ad alta competitività sul lato dei costi. Insomma, l’informazione si può fare anche con i giornalisti, per non dire senza. È una legge di mercato, che vale per le mutande, i souvenirs e persino gli iphone. Non vorremmo valesse anche per l’informazione e peggio ancora a livello di piccole realtà di provincia, in quelle straordinarie nicchie di mercato glocale che – secondo i guru americani dell’informazione – hanno ancora margini per resistere e, chissà, pure per crescere.
Ma quali margini reali esistono se il mercato è in profonda crisi e una legge che dovrebbe tutelare soprattutto le coop di giornalisti, di fatto ne impedisce la nascita con pesanti barriere all’entrata? Basterebbe, per sciogliere il dubbio, osservare che è tuttora vigente il limite dei cinque anni d’attività per le nuove coop, oppure considerare l’asticella del comma 7bis (il codicillo salva-Manifesto, per l’appunto) fissata al 50 per cento. In pratica, una coop di giornalisti e poligrafici che volesse rilevare la propria testata dovrebbe tirare dentro almeno la metà dei dipendenti. Con un rischio, evidente, di sovradimensionamento.
Un’operazione che non può partire con le mani legate ad una percentuale invece che essere affidata ad una buona idea imprenditoriale, in tempi in cui per mettere in piedi una coop non basta il puntello della legge Marcora ma servono un business plan con un break even point credibile, fondi propri (che spesso non ci sono) e nemmeno ci si può appoggiare alle banche che, come noto, finanziano solo chi i soldi li ha già. E serve davvero tanto coraggio, quello che – come don Abbondio – chi non ce l’ha non se lo può dare.
Tutto ciò al netto del fatto che la legge sull’editoria vieta l’ingresso di soci esterni, i cosiddetti finanziatori o sovventori. Il che ha costretto al nanismo le imprese del settore, ammesso che siano riuscite a sopravvivere alla grande crisi. E le nuove realtà che nascono, quasi sempre sono testate completamente ignote all’Inpgi e talvolta ignorate da Fnsi e Ordine dei Giornalisti.
Dunque, i fondi pubblici all’editoria non sono soldi sprecati come racconta la leggenda metropolitana che qualcuno, più o meno consapevolmente, ha voluto far passare per buona. A meno che non si voglia smentire in toto le parole che Albert Camus usò per descrivere l’uomo moderno: “egli fornicava e leggeva i giornali…”.
Massimo D’Onofrio, cdr Corriere del Giorno