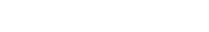Si può avere una seria diffidenza nei confronti delle sovvenzioni statali e avere ad un tempo una ferma convinzione che uno Stato democratico assicuri, all’interno di regole certe, aiuti all’editoria, anche alla carta stampata – in primo luogo locale – che costituisce la struttura portante del libero dibattito e della libera circolazione delle idee anche se di diversa impostazione culturale. Questa elementare regola ha avuto in Italia la naturale formulazione di finanziare (che nel gergo partitocratico significa spartizione), tolto eccezioni, tutti coloro che con la libertà di informazione poco avevano a che fare e che come corrente, sottocorrente, clan e gruppuscolo di partito, facevano finta di fare giornali per poter finanziare sè stessi e il loro gruppo. Ovviamente esistevano ed esistono realtà che per quanto legate ad un partito avevano svolto e svolgono un serio lavoro di diffusione di notizie, idee, contenuti che il dibattito democratico hanno contribuito e contribuiscono a svilupparlo e a promuoverlo. Così come, in questo marasma, vi sono giornali che effettivamente erano e sono giornali che hanno utilizzato i contributi, assieme agli altri mezzi autonomi e alle vendite, per tenere in vita una struttura che fornisce originale e autonoma diffusione di notizie, anche territoriale, che altrimenti non erano a conoscenza dei cittadini, con limiti obiettivi alla conoscenza e alla consapevolezza democratica, almeno quella che resta in un sistema informativo di vero e proprio regime.
Così ci ritroviamo nella paradossale situazione, che si prefigura in tempo di crisi economica, di uno scenario che ha come conseguenza la chiusura ad ogni forma di intervento nel comparto dei media e della carta stampata, che all’inverso è finanziato in quasi tutta Europa e anche negli Usa, mentre coloro che hanno commesso il crimine di dare contributi a chi non li doveva avere finiscono nella categoria degli impuniti.
Il quadro è naturalmente più complicato di questa semplice sommaria ricostruzione, perché non si può dimenticare che nel Belpaese i maggiori quotidiani, per quanto deficitari per loro imperizia, ricevono molti molti soldi per aiuti vari e quindi possono presentarsi come coloro che non hanno interesse al mantenimento di una legge sull’editoria, anzi desiderosi di liberarsi di una rete diffusa di piccoli rompiscatole, sollecitano un totale azzeramento.
Ma andiamo per ordine. In primo luogo gettiamo uno sguardo su uno studio condotto da Rasmus Kleis Nielsen e da Geert Linne-bank del Reuters Institute for the Study of Joumalism (Risj) dell’Università di Oxford in cui vengono analizzati i si-stemi e le modalità dei flussi pubblici all’editoria. I Paesi analizzati sono Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia e negli Usa. Dunque cinque Paesi europei e l’altro grande attore del mondo occidentale, gli Stati Uniti.
Il contributo pubblico dunque esiste in larga parte del mondo democratico, o almeno ritenuto tale. E’ vero comunque che non sempre è documentabile che esista una connessione stretta tra contributo pubblico e capacità di penetrazione dei giornali, così come lo studio citato rileva.
Un altro dato che emerge è che in quasi tutti i paesi analizzati non vi è un’azione di sviluppo da parte degli editori (e in questo caso anche presunti tali, in particolare in Italia) nei confronti dei new-media (si pensi ai giornali online e in genere a tutti i sistemi multimediali della rete internet). Questo anche perché l’intero sistema di contribuzione è basato su una modello superato, datato anni settanta, che non spinge, se non in forma irrilevante e marginale, a utilizzare i sussidi che per i media tradizionali (carta stampata e televisione) ignorando i nuovi protagonisti del mercato.
Dunque, sia pure nei limiti descritti, esiste un intervento dello Stato a favore dell’informazione, partendo proprio dal principio di assicurare la dialettica democratica e la libera circolazione delle idee, tutte le idee.
Bisogna dire che proprio i mutamenti in corso, le nuove tecnologie, le nuove piattaforme di comunicazione giornalistiche, fanno apparire anacronistici i tipi di sussidi sia diretti che indiretti, che vengono elargiti in quasi tutti i paesi, e non vi è ombra di dubbio che senza una profonda riforma sia delle norme che dei soggetti destinatari, questi tipi di interventi sono destinati a scendere sia in efficacia sia in relazione agli obiettivi proposti che sono appunto quelli di assicurare dibattito democratico e circolazione delle idee.”Quanti sono a favore di un nuovo impegno per un sostegno dei media – osserva appunto Rasmus Kleis Nielsen – devono ripensare al ruolo delle testate del servizio pubblico e rivedere il modo con cui i governi possono sostenere delle aziende private che forniscono beni pubblici come l’accesso a forme di giornalismo responsabile e di dibattito pubblico di cui la democrazia può beneficiare”.
Si deve comunque ribadire che in quasi tutte le democrazie (o presunte tali) del XX secolo si ritiene auspicabile che vi sia un sostegno pubblico per i media. Come è ovvio si tratta di un aspetto squisitamente politico.
Ma come si fa ad attuare un intervento corretto e rispondente agli obiettivi di una reale dialettica democratica, considerando anche che, con la trasformazione del settore e il mutamento delle sue basi economiche, con il cambiamento del gusto e delle abitudini delle persone, fissare dei criteri di intervento è ancora più complicato? In Italia poi, la vergognosa formula di distribuzione secondo criteri partitocratici e clanistici, ha finito per creare una situazione paradossale, dove contraddizioni si sommano a contraddizioni e dove diventa quasi impossibile un’azione riformatrice.
“Non sarà facile sviluppare nuove forme di sostegno”, sottolinea ancora Nielsen nel suo studio. “Delle nuove politiche di intervento in un’area cruciale per il funzionamento delle democrazie dovranno poter contare su un ampio sostegno politico, tener conto delle preoccupazioni editoriali e professionali, e nello stesso tempo tentare di coniugare insieme un atteggiamento di neutralità nei confronti delle piattaforme (nessun preconcetto a favore di una o l’altra delle forme di diffusione), di neutralità dei punti di vista (non offrire a nessun politico la possibilità di interferire) e una linea che consenta comunque di vedere le differenze (non si può sostenere tutto), di essere governabili e trasparenti, di non falsare la concorrenza inutilmente, e di essere in grado di superare indenni le varie norme contro gli aiuti statali all’industria emanate per esempio dall’Unione europea”.
E’ un bel dire se si pensa allo squallido mercimonio che si è realizzato nel nostro Paese, con una istituzione preposta che ha finito per elargire fondi a destra e a manca, senza altro criterio se non la spartizione lottizzata e l’assenza di ogni rigorosa disamina dell’operato effettivo del soggetto beneficiario.
Ora la tentazione è un taglio netto e indiscriminato, privo di qualunque interpretazione del problema e con una latente forma di discriminazione nei confronti delle e territoriali testate che si trovano ad essere deboli e schiacciate tra gruppi editoriali tutt’altro che produttivi (beneficiari di aiuti indiretti miliardari) e piccoli truffatori che hanno fatto man bassa negli anni scorsi con la complicità di chi doveva elargire. Le domande sono: come si passa dal vecchio al nuovo senza demagogia e ulteriori ritardi? Quali politiche possono essere giuste per una transizione che non sia traumatica e ingiusta? Ma soprattutto dove sono le energie morali, intellettuali, politiche che possono contribuire a questo passaggio in una fase di crisi devastante della economia, delle istituzioni, della politica? E ancora, come sempre lo studio della Università di Oxford indica, come “passare a un sostegno su larga scala ai new media che implica scelte delicate, come capire ad esempio quale tipo di interesse pubblico è importante sostenere, quale tipo di bene pubblico si desidera distribuire e mettere quindi a punto delle forme dirette o indirette di sostegno che possano effettivamente incoraggiare senza troppi effetti secondari negativi”?
Ci rifacciamo ad una proposta di Frederic Filloux che sul Guardian, sollevando alcune questioni sul modo con cui i media dovrebbero essere sovvenzionati, scrive: “La qualità dell’informazione gioca un ruolo critico in democrazia. Fare un buon giornalismo costa. La conservazione di modelli non commerciali (come NPR o BBC) non lascia dubbi sulla necessità di un sostegno pubblico. L’industria – specialmente la carta stampata – è nel pieno di una radicale e costosa trasformazione e molte testate non hanno le risorse economiche per sostenerla. Dobbiamo contrastare la massiccia ondata di mediocrità nell’industria dell’informazione, con dei ricchi aggregatori impazienti di riconfezionare qualsiasi cosa che soddisfi la loro ossessione”. Detto questo, perché il sostegno pubblico funzioni – suggerisce sempre Filloux – c’è bisogno comunque di alcune condizioni chiave:
1. Management molto severo. Suona ovvio, ma troppo speso il danaro pubblico significa grossi sprechi (come spesso si vede nell’ emittenza radiotelevisiva).
2. Niente open-bar. Cioè: niente fondi a pioggia. Se le sovvenzioni servono a favorire un determinato progetto, si deve poterne valutare i risultati.
3.1 sussidi possono essere diretti o indiretti. Per esempio la sospensione di una tassa opposta alla concessione di un sussidio per una determinata azienda che scende sotto un certo livello di ricavi pubblicitari (come avviene in Francia).
4. Niente sovvenzioni a vita. Solo sostegni per la trasformazione.
Dunque siamo in bilico tra una realtà che indica quanto siano di scarso effetto, se non addirittura di esito negativo, forme di sovvenzione dello Stato per aiutare prodotti e mercati in difficoltà (in questo senso l’editoria non è tanto diversa dall’auto), e la problematica che pone l’editoria come una forma di supporto alla libertà e alla democrazia, che per il modo in cui si è espressa in questi anni è quanto meno discutibile, essendosi dimostrato che il modo in cui i contributi sono stati erogati e il meccanismo corruttivo che l’ha sostenuto ha finito per ottenere un drogaggio perverso del mercato e perché no della stessa democrazia.
Geppy Rippa (direttore della rivista ‘Quaderni Radicali’)
Benvenuto!Collegati al tuo account