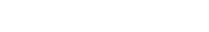Due donne croniste solo all’apparenza distanti, che hanno fatto del proprio coraggio una missione e, della ricerca della verità, una lama da affilare con il solo uso delle parole.
Due scenari lontani, da un lato la Russia Federalista di Vladimir Putin con le sue campagne di guerra silenziosa in Cecenia ed Inguscezia, la morte dei diritti civili e le minacce alla libertà di stampa e al diritto di cronaca. Dall’altro l’Italia degli anni ’60 ed il caso più clamoroso ed insabbiato nell’infinita storia degli errori umani, il Disastro del Vajont, il crollo annunciato dell’omonima diga nel Friuli Venezia Giulia e la condanna a morte di 1917 persone che hanno trovato in quella valle la propria tomba.
Vicende distinte scandite da segreti ed omertà ma narrate attraverso la penna di due croniste testarde e capaci di andare fino in fondo, anche a costo della vita.
Anna Politkovskaja (foto), è stata scrittrice e giornalista del quotidiano di ispirazione liberale Novaja Gazeta, testata fortemente critica nei confronti della classe dirigente post-sovietica. Fin dai primi anni della sua collaborazione (1999), Anna ha voluto spingersi oltre nel proprio lavoro, condannando apertamente il governo di Putin e divenendo testimone imparziale, sul campo, degli abusi commessi ai danni della popolazione civile cecena, dall’esercito russo. Documenti, interviste e reportage da lei firmati che hanno aperto nuove piste di indagine sulle presunte connivenze tra Mosca ed i due Primi Ministri ceceni, Ahmad Kadyrov e suo figlio Ramsan, complici del cd. piano di “cecenizzazione” del Presidente Russo: eliminare i ceceni “cattivi”, quelli a favore della secessione, e salvare solo quelli fedeli al Cremlino. Una campagna che ha dato inizio al genocidio di un intero popolo complice l’ignoranza dell’opinione pubblica internazionale. Anche per questa ragione la Politkovskaja è stata molto più di un’inviata. La giornalista divenne uno dei “negoziatori privilegiati” dalla guerriglia, proprio per aver dato voce alle stragi che si stavano compiendo nel mortificante silenzio dell’informazione nazionale, nonché di quella globale. Ma era pur sempre un personaggio scomodo. Una “reietta”, così si definiva, una nemica impossibile da rieducare. A tal punto da denunciare durante una conferenza a Vienna sulla libertà di stampa nel 2005, e cioè un anno prima del suo assassinio rimasto ancora irrisolto: “Certe volte, le persone pagano con la vita il fatto di dire ad alta voce ciò che pensano. Una persona può perfino essere uccisa semplicemente per avermi dato una informazione. Non sono la sola ad essere in pericolo”. Parole che fungono da testamento ad un’esistenza interrotta per il solo fatto di averla spesa “nel riportare quello che succede a chi non può vederlo”. Era questo secondo Anna, l’obiettivo di cui armarsi per sfidare i tentativi di censura operati dai poteri di turno.
Una definizione lucida del mestiere di giornalista, per giunta “donna”, che ben descrive anche il lavoro svolto in 7 anni – molto prima del 1963, anno della tragedia del Vajont – dalla cronista dell’Unità, Tina Merlin. La giornalista bellunese fu la prima (se non l’unica) a denunciare gli espropri di interi ettari dei terreni in corso nel Friuli ed i rischi di frana derivanti dalla costruzione della diga tanto voluta dalla Società di Elettricità Sade (poi assorbita da Enel). E lo fece raccogliendo le preoccupazioni e le testimonianze della gente del luogo, i montanari di Erto, subito dopo la prime avvisaglie, tre anni in anticipo dalla tragedia, che videro il distacco di ben 800mila metri cubi di terra dal Monte Toc, il 4 novembre del 1960. La Merlin andò ben oltre il proprio compito di cronista. Inaugurò una campagna di informazione sui pericoli del progetto industriale durante tutto il periodo di costruzione del bacino idro-elettrico. Un’iniziativa per cui fu anche incriminata per “diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico” solo per aver firmato degli articoli, per aver fatto fino in fondo il proprio mestiere. Per poi venire assolta dal Tribunale di Milano quando il disastro si era ormai consumato.
“Magari fossi riuscita a turbare l’ordine pubblico”, queste saranno le sue parole dettate dall’impotenza del momento ma che nulla tolgono alla lucidità del racconto di una cronista che non ha mai avuto paura di andare alla radice dei fatti per combattere “l’ipocrisia che invoca il silenzio di fronte ai lutti e alle devastazioni”.
Manuela Avino
Benvenuto!Collegati al tuo account